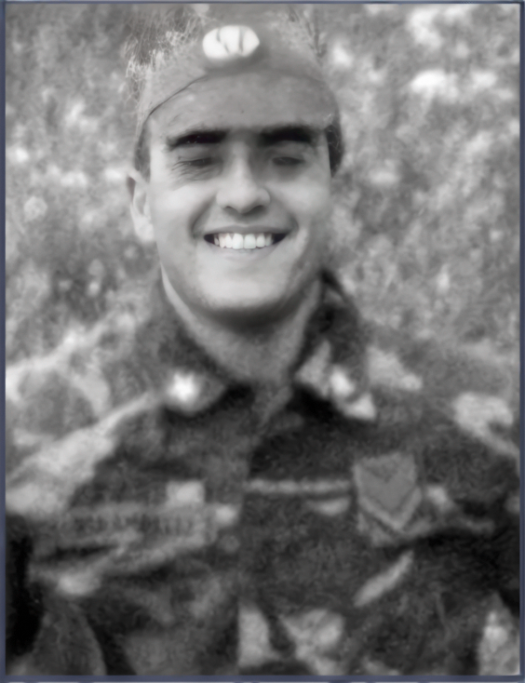Capodanno pisano

Il cosiddetto Calendario Pisano, o stile dell’Incarnazione al modo pisano, rappresentava un particolare sistema di computo del tempo in uso a Pisa e in altre zone dell’attuale Toscana fino alla metà del XVIII secolo. La peculiarità di questo calendario risiedeva nella scelta della data di inizio dell’anno, fissata al 25 marzo, giorno in cui si celebra l’Annunciazione della Vergine Maria secondo il calendario liturgico. Tale data anticipava di nove mesi e sette giorni l’inizio dell’anno rispetto allo “stile moderno” o “stile della Circoncisione”, che fissa al 1º gennaio il primo giorno dell’anno. Questa modalità di calcolo del tempo era radicata nella cultura pisana e contraddistingueva l’identità della città e del suo territorio.
L’abolizione del Calendario Pisano avvenne per decreto del granduca Francesco Stefano di Lorena il 20 novembre del 1749. Con tale provvedimento si stabilì che in tutto il territorio toscano il nuovo anno dovesse iniziare il 1º gennaio successivo, adeguandosi così al calendario gregoriano già in uso nel resto d’Europa. In conseguenza di questa decisione, lo Stato pisano, comprendente approssimativamente le attuali province di Pisa e Livorno, dovette conformarsi alle nuove disposizioni, abbandonando definitivamente l’antico sistema.
Nonostante la sua abolizione, il Calendario Pisano ha continuato a suscitare interesse storico e culturale. Verso la fine degli anni ’80 del Novecento, la Parte di Mezzogiorno del Gioco del Ponte si fece promotrice della rievocazione delle celebrazioni legate a questo evento. In seguito, anche l’Associazione Amici del Gioco del Ponte contribuì significativamente alla conservazione e alla promozione di questa tradizione, assumendo il ruolo di ente coordinatore delle associazioni impegnate nelle attività culturali connesse al Capodanno Pisano. A partire dal 2000, l’organizzazione delle celebrazioni è stata affidata al Comune e alla Provincia di Pisa, conferendo ufficialità all’evento e garantendone la continuità nel panorama delle manifestazioni cittadine.
Un aspetto peculiare legato all’inizio dell’Anno Pisano è la sua scansione mediante un orologio solare. Nel Duomo di Pisa, un raggio di sole entrava da una finestra detta Aurea e colpiva una zona prossima all’altare maggiore esattamente a mezzogiorno, segnando così l’inizio del nuovo anno secondo la tradizione pisana. Tuttavia, a causa delle modifiche architettoniche apportate nel XVII secolo, questo meccanismo perse la sua efficacia. Nel corso del XIX e XX secolo, fu ripristinato sfruttando una differente finestra e stabilendo come bersaglio una mensolina a forma di uovo, situata su un pilastro vicino al luogo in cui venne riassemblato il pergamo di Giovanni Pisano nel 1926.
Le celebrazioni per l’inizio dell’Anno Pisano si aprono con un corteo storico della Repubblica Marinara, a cui prendono parte anche i gonfaloni dei comuni pisani, conferendo solennità e fascino all’evento. Segue una breve cerimonia religiosa, che si conclude esattamente a mezzogiorno, momento in cui l’orologio solare segna l’ingresso nell’anno nuovo secondo la tradizione pisana. Questa rievocazione rappresenta non solo un omaggio al passato, ma anche un’occasione per riaffermare l’identità storica di Pisa e mantenere viva la memoria di un sistema cronologico che per secoli ha regolato la vita della città e del suo territorio.
Roberto Marchetti
Fonte: turismo.pisa.it. Foto: turismo.pisa.it